
Desideravo viaggiare nell’interno dello stato dell’Ohio prima di “toccare i laghi” (per usare la formula di rito), situati vicino alla piccola città di Sandusky, dove il nostro itinerario ci avrebbe fatti passare prima di raggiungere il Niagara. Siamo quindi ripartiti da Saint Louis per la strada che avevamo fatto all’andata e siamo risaliti verso Cincinnati.
Poiché il giorno della partenza il tempo era molto bello e il battello, che avrebbe dovuto mettersi in moto di buon’ora, aveva rinviato per la terza o la quarta volta il suo disormeggio, spostandolo infine al pomeriggio, ci siamo recati a cavallo al vecchio villaggio francese di Carondelet, soprannominato Vide Poche, Tasca Vuota, situato sul bordo del fiume. L’accordo era che il battello ci avrebbe caricati strada facendo. Il posto si riduceva a qualche catapecchia e a due o tre bettole e le condizioni della dispensa, che non conteneva nulla, sembravano giustificarne il soprannome. Alla fine, tornando indietro di circa mezzo miglio, abbiamo finito per trovare una casa isolata dove ci siamo procurati del prosciutto e del caffè e dove ci siamo installati per attendere l’arrivo del battello, che avremmo visto spuntare da lontano dal prato davanti alla porta d’ingresso.
Si trattava di una taverna di villaggio pulita e senza pretese e ci siamo ristorati in una piccola stanza ammobiliata contenente un letto, decorata con vecchi quadri a olio che provenivano probabilmente da qualche monastero o cappella cattolica. Il cibo era buono e servito con molta pulizia. La casa era tenuta da una tipica coppia di vecchi sposi, con cui abbiamo avuto una lunga conversazione, che costituivano senza dubbio un campione eccellente delle genti del West.
Il battello ha fatto la sua comparsa alla fine della giornata e noi abbiamo detto addio a quella povera vecchia e al marito vagabondo. Ci siamo diretti verso l’approdo più vicino, siamo saliti a bordo del Messenger, ci siamo installati nella nostra vecchia cabina e abbiamo cominciato a discendere il Mississippi.
 Se la risalita del fiume e il lento avanzare controcorrente aveva costituito una navigazione difficile, la discesa di questo fiume torbido era quasi peggiore, perché il battello, che filava alla velocità di dodici o quindici nodi, doveva aprirsi un varco in un labirinto di tronchi, che, nell’oscurità, non si vedevano abbastanza in tempo per evitarli. La campana non ha fatto silenzio per cinque minuti in tutta la notte e, dopo ogni segnale, il battello era scosso, a volte da uno, a volte da una dozzina di colpi in successione, il più leggero dei quali sembrava più che sufficiente a sfondare la sua fragile carena, come se fosse un timballo. Nel buio, le sue acque sporche sembravano popolate di mostri: erano delle forme nere che roteavano sulla superficie o che vi risalivano verticalmente, dopo che il battello le aveva spinte verso il basso. Capitava che le macchine si fermassero per un lungo intervallo, allora questi ostacoli si ammucchiavano strettamente e in così gran numero davanti, dietro e ai lati del battello che noi ci trovavamo accerchiati, come al centro di un’isola galleggiante, e obbligati ad aspettare che si separassero, come delle nuvole nere cacciate dal vento, per aprirci un canale a poco a poco.
Se la risalita del fiume e il lento avanzare controcorrente aveva costituito una navigazione difficile, la discesa di questo fiume torbido era quasi peggiore, perché il battello, che filava alla velocità di dodici o quindici nodi, doveva aprirsi un varco in un labirinto di tronchi, che, nell’oscurità, non si vedevano abbastanza in tempo per evitarli. La campana non ha fatto silenzio per cinque minuti in tutta la notte e, dopo ogni segnale, il battello era scosso, a volte da uno, a volte da una dozzina di colpi in successione, il più leggero dei quali sembrava più che sufficiente a sfondare la sua fragile carena, come se fosse un timballo. Nel buio, le sue acque sporche sembravano popolate di mostri: erano delle forme nere che roteavano sulla superficie o che vi risalivano verticalmente, dopo che il battello le aveva spinte verso il basso. Capitava che le macchine si fermassero per un lungo intervallo, allora questi ostacoli si ammucchiavano strettamente e in così gran numero davanti, dietro e ai lati del battello che noi ci trovavamo accerchiati, come al centro di un’isola galleggiante, e obbligati ad aspettare che si separassero, come delle nuvole nere cacciate dal vento, per aprirci un canale a poco a poco. Malgrado tutto la mattina, come previsto, eravamo in vista di quella detestabile palude che si chiama Cairo, dove abbiamo ormeggiato, per prendere la legna, di fianco a una barca con i pezzi di carpenteria sconnessi e con la scritta Coffee House sul fianco. Suppongo che si trattasse del paradiso galleggiante dove le genti correvano a rifugiarsi quando le loro case sparivano per un mese o due sotto il Mississippi. Dopo aver oltrepassato una linea gialla che attraversava la corrente, guardando verso sud abbiamo avuto il piacere di vedere quel fiume detestabile deviare e orientare i suoi fanghi e il suo carico sinistro in direzione di New Orleans e ci siamo ritrovati sulle limpide acque del fiume Ohio, con la speranza di non rivedere mai più il Missisippi, se non in un incubo. Lasciarlo a vantaggio del suo vicino scintillante è stato come passare dalla sofferenza al benessere, come uscire da un orribile sogno per la gradevole realtà.
Siamo arrivati a Louisville la sera del quarto giorno e siamo stati felici di approfittare del suo eccellente hotel. Ci siamo imbarcati il giorno dopo sul Ben Franklin, un bel battello che effettuava il servizio postale e abbiamo raggiunto Cincinnati poco dopo mezzanotte. Un po’ stufi di dormire sulle assi delle cuccette, siamo rimasti in piedi, pronti a scendere a terra seduta stante e, dopo aver superato i ponti scuri di altri battelli e attraversato dedali di macchinari e di fusti di melassa bucati, siamo andati a svegliare il portiere dell’hotel dove avevamo già soggiornato e, poco dopo, con nostra grande gioia, siamo stati confortevolmente sistemati.
 Abbiamo passato una sola giornata a Cincinnati, poi abbiamo ripreso il nostro viaggio verso Sandusky. La nostra prima tappa era Columbus, distante centoventi miglia, ma la strada era rivestita da un capo all’altro di asfalto (benedizione rara!), e si viaggiava alla velocità media di sei miglia all’ora.
Abbiamo passato una sola giornata a Cincinnati, poi abbiamo ripreso il nostro viaggio verso Sandusky. La nostra prima tappa era Columbus, distante centoventi miglia, ma la strada era rivestita da un capo all’altro di asfalto (benedizione rara!), e si viaggiava alla velocità media di sei miglia all’ora. Siamo partiti alle otto del mattino a bordo di una grande vettura di posta rossa, le cui guance gonfie e rubiconde la facevano sembrare sul punto di una congestione cerebrale. Idropica la carrozza lo era sicuramente, dato che accoglieva all’interno una dozzina di passeggeri, ma aggiungo con piacere che, essendo quasi nuova, era pulita e rutilante e percorreva con gioioso fracasso le strade di Cincinnati.
La strada attraversava una bella campagna, riccamente coltivata, il cui rigoglio prometteva un raccolto abbondante. A volte costeggiavamo un campo di mais, i cui grossi gambi erano talmente dritti da somigliare a una piantagione di bastoni da passeggio, a volte passavamo accanto a un piccolo recinto nel quale il grano verde cresceva in mezzo a un dedalo di ceppi. Dappertutto c’era la brutta e primitiva recinzione a zig-zag, ma le fattorie erano tenute bene e, a parte questa differenza, sembrava di essere nel Kent.
Ci fermavamo spesso in alberghi lungo la strada, sempre tetri e silenziosi. Il vetturino saltava a terra, andava a riempire il secchio d’acqua e dava da bere ai cavalli. Era raro che ci fosse qualcuno ad aiutarlo, i fannulloni erano molto rari e non c’era neanche un garzone di scuderia con cui scambiare una battuta. A volte, dopo il cambio dell’equipaggio, si aveva qualche difficoltà a rimettersi in marcia a causa del metodo impiegato per domare un cavallo giovane: lo si catturava, lo si bardava contro la sua volontà e lo si attaccava seduta stante a una diligenza, anche se ci si riusciva solo dopo molte scalciate e un violento combattimento, per ripartire poi allo stesso piccolo trotto.
Talvolta, quando ci fermavamo per cambiare i cavalli, c’erano due o tre uomini oziosi mezzi ubriachi che venivano verso di noi con le mani in tasca o che trascorrevano il tempo seduti sulle sedie a dondolo, appoggiati a un davanzale o appollaiati sulla balaustrata di una veranda, e, poiché non avevano granché da dire né a noi né fra di loro, si accontentavano di restare là a guardare oziosamente la vettura e i cavalli. Di solito, il padrone dell’albergo era della partita e sembrava essere, fra tutti, il meno interessato a quello che accadeva nell’edificio. Di fatto, fra lui e la taverna c’era la stessa relazione che c’era fra il cocchiere e la diligenza carica di passeggeri: qualunque cosa succedesse nella sua sfera di attività, egli rimaneva piuttosto indifferente e perfettamente distaccato.
Abbiamo viaggiato tutta la notte. A poco a poco è cominciato a spuntare il giorno e i primi raggi di un caldo sole hanno illuminato una miserabile distesa di erbacce, di alberi smorti e di sordide capanne dall’aspetto triste e derelitto al più alto grado. Una landa di vegetazione fetida e nociva cresceva sulla superficie dell’acqua stagnante, dove le rare impronte di piedi sul suolo spugnoso erano invase da funghi velenosi, che spuntavano anche dalle fessure dei muri e dal pavimento delle capanne. E questa scena ripugnante si trovava alle soglie della città. Ma il posto era stato acquistato anni prima e il suo proprietario, a cui lo Stato avrebbe potuto chiedere la restituzione, era introvabile. Perciò esso restava là, in mezzo alle coltivazioni e agli altri appezzamenti valorizzati, come il luogo maledetto di un crimine odioso.
 Siamo arrivati a Columbus poco prima delle sette e vi abbiamo passato la giornata e la notte, per concederci un po’ di riposo. Eravamo installati in modo confortevole in un hotel molto grande e non ancora finito, il Neill House, i cui appartamenti lussuosi, arredati con lucidi mobili di noce, erano distribuiti come in una dimora italiana e si aprivano su di un portico armonioso e una veranda di pietra. La città, pulita e graziosa, era naturalmente destinata a ingrandirsi considerevolmente ed essendo la capitale dello stato dell’Ohio e la sede del parlamento, pretendeva di avere un certo peso e una certa considerazione.
Siamo arrivati a Columbus poco prima delle sette e vi abbiamo passato la giornata e la notte, per concederci un po’ di riposo. Eravamo installati in modo confortevole in un hotel molto grande e non ancora finito, il Neill House, i cui appartamenti lussuosi, arredati con lucidi mobili di noce, erano distribuiti come in una dimora italiana e si aprivano su di un portico armonioso e una veranda di pietra. La città, pulita e graziosa, era naturalmente destinata a ingrandirsi considerevolmente ed essendo la capitale dello stato dell’Ohio e la sede del parlamento, pretendeva di avere un certo peso e una certa considerazione. Poiché il giorno dopo non era prevista alcuna diligenza sull’itinerario che desideravo seguire, ho noleggiato per un prezzo ragionevole un extra, che ci portasse fino a Tiffin, una piccola località dalla quale partiva il treno per Sandusky. La vettura era una normale diligenza, come quelle che ho già descritto, con quattro cavalli e con il cambio predisposto come per le altre diligenze, ma era esclusivamente nostra per tutta la durata del viaggio. Per assicurarci di trovare delle buone bestie alle stazioni di posta ed evitare di essere disturbati da estranei, i proprietari avevano inviato un agente, seduto di fianco al conducente, che ci doveva accompagnare fino a destinazione. Così scortati e muniti di un paniere pieno di gustosa carne fredda, di frutta e di vino, ci siamo messi in cammino alle sei e mezza dell’indomani, pieni d’entusiasmo, contenti di essere fra di noi e pronti ad affrontare un tragitto accidentato.
Era una fortuna che fossimo in questa disposizione d’animo perché la strada seguita quel giorno era tale da far scendere di qualche pollice sotto a Tempesta un umore che non fosse più che saldamente posizionato sul Bello Stabile. Un momento ci ritrovavamo a rotolare l’uno sull’altro sul pavimento della vettura, il momento dopo sbattevamo con il cranio contro il tetto.
Capitava che un fianco della vettura fosse affondato nel fango e che noi ci aggrappassimo all’altro o che la parte anteriore fosse appoggiata sulla coda degli animali o che si impennasse in una posizione spaventosa, mentre i quattro cavalli, giunti in cima a una collina insormontabile si fermavano di colpo e guardavano indietro con l’aria di dire: “Sbardateci. E’ un’impresa impossibile.” I cocchieri, che se la cavavano in modo miracoloso su quelle strade, per aprirsi un passaggio fra le buche e le paludi torcevano e attorcigliavano il loro tiro come se fosse un cavatappi. Capitava di vederli con le redini in mano, all’apparenza non impegnati a condurre, o come se, per gioco, fossero alla guida di cavalli immaginari, mentre gli animali della pariglia di testa ci guardavano da dietro la vettura, come se avessero l’intenzione di salirvi. Abbiamo fatto una parte del percorso su di una strada costruita gettando dei tronchi d’abete su di un terreno paludoso e lasciandoli poi sedimentare. Il più leggero sobbalzo della pesante vettura nel passaggio fra un tronco e l’altro sembrava sufficiente a slogare tutte le ossa del corpo umano. Non c’è un’altra circostanza in cui si possa provare un insieme di sensazioni simili, se non forse tentando di salire sulla cupola della cattedrale di Saint Paul in omnibus. Mai, nemmeno una volta, la diligenza ha conosciuto una posizione, un’inclinazione o un movimento a cui si sia abituati su questo tipo di veicoli e non una volta l’esperienza si è avvicinata a quella che si può avere su un qualsiasi mezzo di trasporto provvisto di ruote.
Malgrado ciò era una bella giornata, la temperatura era deliziosa, e, benché avessimo lasciato l’estate dietro di noi nell’Ovest e stessimo abbandonando rapidamente anche la primavera, ci stavamo dirigendo verso il Niagara e poi verso casa. Intorno a mezzogiorno siamo scesi dalla vettura in un piacevole bosco, abbiamo pranzato su di un tronco d’albero abbattuto e abbiamo lasciato il cibo eccedente a un indigeno e gli avanzi ai maiali, che in questa parte del paese abbondano come grani di sabbia sulla spiaggia (con grande soddisfazione della nostra intendenza militare in Canada), poi ci siamo rimessi allegramente in viaggio.
Scendeva la sera e il sentiero si faceva sempre più stretto, fino a quando finiva per perdersi fra gli alberi e il nostro conducente sembrava trovare la direzione d’istinto. Almeno avevamo la certezza che non si sarebbe addormentato, dato che non passava molto tempo senza che una ruota urtasse violentemente contro un ceppo passato inosservato e che egli aveva tutto l’interesse a tenersi saldamente per evitare di cadere dal suo sedile. Non dovevamo neanche preoccuparci dei pericoli derivanti dalla velocità, perché su questo terreno dissestato le bestie ce la mettevano tutta per andare al passo. Quanto a fare uno scarto non c’era lo spazio e neanche un branco di elefanti sarebbe riuscito a correre in un bosco simile con una diligenza come la nostra alle calcagna. Perciò abbiamo continuato il nostro cammino alla meno peggio e non senza soddisfazioni.
I ceppi d’albero sono una strana particolarità degli spostamenti in America. All’imbrunire, esse offrono a un occhio inesperto delle illusioni abbastanza straordinarie per la loro varietà e il loro realismo. Ecco un’urna greca in un campo deserto; ecco una donna che piange su di una tomba; là c’è un vecchio signore con i pollici infilati, come d’abitudine, nel giro manica del gilet bianco; laggiù c’è uno studente immerso in un libro, qui c’è un negro accovacciato. E poi un cavallo, un cane, un cannone, un uomo armato, un gobbo che si libera del mantello e che avanza nella luce. Queste forme non si componevano secondo la mia fantasia, ma sembravano imporsi alla mia mente, volente o nolente che fossi, ed erano divertenti come le proiezioni di una lanterna magica. Stranamente, io ci vedevo i personaggi un tempo familiari e da lungo tempo dimenticati dei miei libri d’infanzia.
Ben presto, però, era troppo buio per questo genere di divertimento e gli alberi erano così vicini che i loro rami urtavano la vettura da ogni lato e ci obbligavano a tenere dentro la testa. C’è anche stato un temporale che è durato tre ore buone, con lampi molto luminosi, azzurrognoli e di lunga durata. Vedendo quei bagliori intensi attraverso l’intrico dei rami e udendo il tuono che si ripercuoteva lugubremente al di sopra della cima degli alberi, si era portati a pensare che in quel momento c’erano dei luoghi più ospitali di quei fitti boschi.
 Finalmente, fra le dieci e le undici di sera, sono apparse in lontananza alcune luci fioche. Davanti a noi si stendeva il villaggio indiano di Upper Sandusky, dove dovevamo restare fino al mattino.
Finalmente, fra le dieci e le undici di sera, sono apparse in lontananza alcune luci fioche. Davanti a noi si stendeva il villaggio indiano di Upper Sandusky, dove dovevamo restare fino al mattino. Al Log Inn, il solo albergo del posto, erano già andati tutti a dormire, ma sono venuti subito ad aprirci la porta quando abbiamo bussato e ci è stato servito il tè in una sorta di cucina o sala comune con i muri tappezzati di vecchi giornali. La camera da letto dove mia moglie ed io siamo stati accompagnati era ampia, spettrale, con il soffitto basso e con un mucchio di legna secca e imbiancata nel focolare. Le due porte, una di fronte all’altra, sprovviste di chiavistello, si aprivano sulla notte buia e sulla natura selvaggia ed erano costruite in modo tale che, quando c’era una corrente d’aria, l’apertura dell’una provocava la chiusura dell’altra. Non ricordo di aver mai incontrato prima una simile innovazione in materia di architettura domestica. Essa mi si è rivelata dopo che ero andato a letto e non ha mancato di preoccuparmi perché nel mio nécessaire avevo una somma considerevole in oro, destinata a coprire le spese di viaggio. Ma una parte dei bagagli, accatastati contro i pannelli della porta, ha ben presto risolto il problema e io ho pensato che il mio sonno non sarebbe più stato disturbato, ma è andata ben altrimenti.
Il mio amico di Boston è salito a coricarsi da qualche parte sotto ai tetti, dove un altro pensionante stava già russando sonoramente. Ma, divorato dai parassiti e incapace di resistere oltre, si è di nuovo alzato per andare a rifugiarsi nella diligenza, che prendeva aria davanti alla casa. L’iniziativa non si è dimostrata molto felice, perché i maiali l’avevano fiutato e, considerando la diligenza una specie di pasticcio farcito di carne, si sono messi a girarle attorno grugnendo in un modo così orribile che lui non ha più osato uscire ed è rimasto là a tremare di freddo fino al mattino. Quando alla fine ne è sceso, non lo si è nemmeno potuto riscaldare con un bicchiere di brandy: nei villaggi indiani, il governo, ispirato da un’intenzione buona e saggia, ha proibito agli osti di vendere alcool. Tuttavia questa precauzione non ha sortito un grande effetto perché gli Indiani si procuravano a poco prezzo un alcool di cattiva qualità dai venditori ambulanti.
 Il luogo è abitato da Indiani Wyandot. Al momento del pranzo, a tavola c’era un vecchio signore affabile che da molti anni conduceva con loro i negoziati per conto del governo degli Stati Uniti e aveva appena concluso un trattato che li impegnava, in cambio di una certa somma versata annualmente, a trasferirsi sulle terre che erano state loro assegnate a ovest del Mississippi, a una certa distanza da Saint-Louis, l’anno seguente. Mi ha parlato in modo commovente del loro profondo attaccamento per i luoghi della propria infanzia e in particolare per le sepolture e della loro riluttanza ad allontanarsene. Egli aveva assistito a molti trasferimenti e sempre con tristezza, anche se sapeva che essi partivano per il loro bene. Uno o due giorni prima, in una capanna costruita a questo scopo, i cui pezzi di legno giacevano ancora davanti all’albergo, essi si erano riuniti per deliberare se la tribù dovesse andarsene o restare. Finito il discorso, i favorevoli e i contrari si erano messi gli uni di fronte agli altri e avevano votato. Appena è stato reso noto il risultato, la minoranza (molto numerosa) si è piegata di buon grado e non ha più manifestato alcun tipo di opposizione.
Il luogo è abitato da Indiani Wyandot. Al momento del pranzo, a tavola c’era un vecchio signore affabile che da molti anni conduceva con loro i negoziati per conto del governo degli Stati Uniti e aveva appena concluso un trattato che li impegnava, in cambio di una certa somma versata annualmente, a trasferirsi sulle terre che erano state loro assegnate a ovest del Mississippi, a una certa distanza da Saint-Louis, l’anno seguente. Mi ha parlato in modo commovente del loro profondo attaccamento per i luoghi della propria infanzia e in particolare per le sepolture e della loro riluttanza ad allontanarsene. Egli aveva assistito a molti trasferimenti e sempre con tristezza, anche se sapeva che essi partivano per il loro bene. Uno o due giorni prima, in una capanna costruita a questo scopo, i cui pezzi di legno giacevano ancora davanti all’albergo, essi si erano riuniti per deliberare se la tribù dovesse andarsene o restare. Finito il discorso, i favorevoli e i contrari si erano messi gli uni di fronte agli altri e avevano votato. Appena è stato reso noto il risultato, la minoranza (molto numerosa) si è piegata di buon grado e non ha più manifestato alcun tipo di opposizione. Abbiamo incontrato in seguito alcuni di questi Indiani sfortunati, che cavalcavano piccoli cavalli a pelo lungo. Somigliavano talmente a degli zingari, che, se fossimo stati in Inghilterra, avrei pensato che appartenessero a questo popolo nomade e irrequieto.
Abbiamo lasciato il villaggio subito dopo colazione e ci siamo rimessi in cammino, su di una strada che era, se possibile, ancora peggiore di quella della vigilia e intorno a mezzogiorno siamo arrivati a Tiffin, dove abbiamo lasciato la vettura. Alle due abbiamo preso un treno che procedeva molto lentamente perché i binari erano di costruzione mediocre ed erano posati su di un terreno umido e paludoso, ma siamo arrivati a Sandusky in tempo per la cena. Siamo scesi in un piccolo hotel confortevole ai bordi del lago Erie, vi abbiamo passato la notte nell’attesa che un battello diretto a Buffalo vi facesse scalo. Questa località sonnolenta e di poco interesse somigliava all’entroterra di una stazione balneare inglese fuori stagione.
Il giorno dopo il nostro arrivo, una domenica, stavamo pranzando di buon’ora quando è comparso un battello che ha accostato al molo. Venendo a sapere che aveva come destinazione Buffalo, ci siamo imbarcati in tutta fretta e abbiamo lasciato Sandusky dietro di noi.
Era una grande nave di cinquecento tonnellate, sistemata in modo piacevole, ma le sue macchine ad alta pressione mi facevano provare la stessa sensazione che se avessi alloggiato al piano terra di una polveriera. Trasportava un carico di farina, alcuni fusti della quale erano depositati sul ponte. Il capitano, venuto a scambiare qualche parola con noi e a presentare un amico, si è seduto a cavalcioni su di una di queste botti, come un Bacco, e, tirando fuori dalla tasca un grosso coltello a serramanico, ha cominciato a tagliare dei sottili trucioli mentre continuava a parlare. E ci metteva una tale operosità e buona volontà che, se non fosse stato prontamente chiamato altrove, la botte si sarebbe presto trasformata in un mucchio di ritagli e di avanzi.
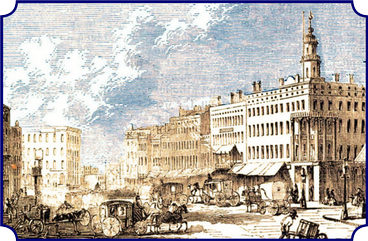 A mezzanotte, dopo esserci fermati in uno o due posti molto piatti, punteggiati di fari tozzi simili a dei mulini a vento privi di pale che ricordavano l’immagine di un paesaggio olandese, con delle dighe basse che si protendevano nel lago, abbiamo toccato Cleveland e vi siamo rimasti fino alle nove del mattino.
A mezzanotte, dopo esserci fermati in uno o due posti molto piatti, punteggiati di fari tozzi simili a dei mulini a vento privi di pale che ricordavano l’immagine di un paesaggio olandese, con delle dighe basse che si protendevano nel lago, abbiamo toccato Cleveland e vi siamo rimasti fino alle nove del mattino. Nutrivo una grande curiosità verso questa città, dopo che a Sandusky avevo visto un esemplare della sua letteratura sotto forma di un giornale che trattava in termini energici il recente arrivo a Washington di Lord Ashburton, incaricato di risolvere una disputa fra il governo degli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Vi si informava il lettore che, dopo che l’America aveva corretto l’Inghilterra nella sua prima infanzia e dopo che l’aveva corretta di nuovo in gioventù, era necessario che la correggesse ancora una volta nella sua maturità. Si diceva a tutti gli Americani che, se il signor Webster avesse fatto il suo dovere nel corso dei negoziati e rimandato il lord inglese in patria, si sarebbe potuto, nel giro di due anni, “cantare Yankee Doodle a Hyde Park e Hail Columbia alla corte di Westminster!”
Ho trovato la città molto graziosa e ho avuto la soddisfazione di vedere la facciata della sede del foglio che ho appena citato. Non ho avuto il piacere di incontrare il bello spirito che aveva redatto il paragrafo in questione, ma non ho dubbi che si trattava di un uomo prodigioso nel suo genere, che godeva di un’alta reputazione in seno all’elite della città.
 Alle otto di sera siamo giunti alla città di Erie, dove abbiamo sostato per un’ora, prima di proseguire per Buffalo, dove siamo arrivati fra le cinque e le sei del mattino e dove abbiamo fatto colazione. Ormai le cascate erano troppo vicine per attendere ancora e alle nove siamo saliti sul treno con destinazione Niagara.
Alle otto di sera siamo giunti alla città di Erie, dove abbiamo sostato per un’ora, prima di proseguire per Buffalo, dove siamo arrivati fra le cinque e le sei del mattino e dove abbiamo fatto colazione. Ormai le cascate erano troppo vicine per attendere ancora e alle nove siamo saliti sul treno con destinazione Niagara. Era una giornata triste e fredda, con una nebbiolina che rendeva umida l’aria. Gli alberi di quella contrada settentrionale erano lugubri e spogli. Ogni volta che il treno si fermava, io tendevo l’orecchio in attesa di un rombo sordo e scrutavo l’orizzonte dalla parte del fiume dove sapevo che dovevano esserci le cascate. Mi aspettavo a ogni istante di vederne gli spruzzi. Qualche minuto prima dell’arrivo ho visto due grandi nubi bianche salire lentamente e maestosamente dalle profondità della terra. Nient’altro. Soltanto quando siamo scesi ho percepito, per la prima volta, il movimento possente delle acque e ho sentito il suolo tremare sotto i piedi.
La riva scoscesa del fiume era resa scivolosa dalla pioggia e dal ghiaccio, che cominciava a fondere. Non so in che modo sono sceso, ma ben presto mi sono ritrovato in basso, assordato dal rombo e quasi accecato dagli spruzzi, bagnato fino alle ossa. Mentre scalavo le rocce, mi hanno raggiunto due ufficiali inglesi, che venivano dall’altra riva. Ci trovavamo ai piedi della cascata dal lato americano. Vedevo un enorme torrente d’acqua gettarsi nell’abisso, ma non avevo nozione della sua forma o posizione, solo un vago senso di immensità.
 Ho cominciato a farmi un’idea delle sue dimensioni solo quando abbiamo attraversato il fiume ingrossato a bordo di un piccolo traghetto, a monte delle due cateratte. Ero come attonito, incapace di abbracciare l’immensità del paesaggio. Ho dovuto aspettare di mettere piede sulla roccia chiamata Table Rock perché la caduta d’acqua di un verde intenso mi apparisse – Signore Iddio!- in tutta la sua potenza e maestà.
Ho cominciato a farmi un’idea delle sue dimensioni solo quando abbiamo attraversato il fiume ingrossato a bordo di un piccolo traghetto, a monte delle due cateratte. Ero come attonito, incapace di abbracciare l’immensità del paesaggio. Ho dovuto aspettare di mettere piede sulla roccia chiamata Table Rock perché la caduta d’acqua di un verde intenso mi apparisse – Signore Iddio!- in tutta la sua potenza e maestà. Quando ho sentito quanto mi trovassi vicino al Creatore, il primo effetto vivo - immediato e duraturo allo stesso tempo - di quel formidabile spettacolo è stato un sentimento di pace. Serenità, quiete, tranquillo ricordo degli scomparsi, meditazione sul riposo eterno e sulla felicità: niente che si apparentasse alla tristezza o alla paura. Il Niagara ha impresso nel mio cuore un’immagine di bellezza, che resterà immutabile e indelebile fino a quando i suoi battiti saranno cessati per sempre.
 Nel corso dei dieci giorni memorabili che abbiamo passato in questo luogo incantevole, le vicissitudini della vita quotidiana si sono dileguate dal mio spirito e sono sfumate in lontananza. Quante voci mi hanno parlato nel fragore delle acque, quanti visi ormai scomparsi mi hanno guardato nello scintillio delle loro profondità, quante promessa celestiale splendeva in quelle lacrime angeliche, goccioline iridate che ricadevano sotto forma di pioggia e che si combinavano in splendidi arcobaleni cangianti!
Nel corso dei dieci giorni memorabili che abbiamo passato in questo luogo incantevole, le vicissitudini della vita quotidiana si sono dileguate dal mio spirito e sono sfumate in lontananza. Quante voci mi hanno parlato nel fragore delle acque, quanti visi ormai scomparsi mi hanno guardato nello scintillio delle loro profondità, quante promessa celestiale splendeva in quelle lacrime angeliche, goccioline iridate che ricadevano sotto forma di pioggia e che si combinavano in splendidi arcobaleni cangianti! In tutto quel tempo non ho mai abbandonato la costa canadese, dove mi ero recato sin dall’inizio. Non ho attraversato il fiume, perché sapevo che sull’altra sponda c’erano delle persone e in luoghi simili non si cerca di avere rapporti con estranei. Per essere felice mi bastava vagare tutto il giorno, per abbracciare le cascate da tutti i punti possibili; fermarmi ai bordi della grande cascata  Horse-Shoe, dove la massa d’acqua accelerava avvicinandosi al dirupo per arrestarsi un attimo prima di gettarsi nell’abisso; scendere al livello del fiume per vedere dal basso l’abbattersi della cataratta; arrampicarmi sulle alture circostanti e contemplarla attraverso gli alberi; vedere il corso d’acqua ribollire nelle rapide e lanciarsi verso il suo spaventoso tuffo; attardarmi all’ombra delle rocce ieratiche, tre miglia più a valle; osservare il fiume che, rimescolato da una causa invisibile, si sollevava, turbinava e risvegliava mille eco sotto la superficie, lontano dal suo salto da gigante.
Horse-Shoe, dove la massa d’acqua accelerava avvicinandosi al dirupo per arrestarsi un attimo prima di gettarsi nell’abisso; scendere al livello del fiume per vedere dal basso l’abbattersi della cataratta; arrampicarmi sulle alture circostanti e contemplarla attraverso gli alberi; vedere il corso d’acqua ribollire nelle rapide e lanciarsi verso il suo spaventoso tuffo; attardarmi all’ombra delle rocce ieratiche, tre miglia più a valle; osservare il fiume che, rimescolato da una causa invisibile, si sollevava, turbinava e risvegliava mille eco sotto la superficie, lontano dal suo salto da gigante.
 Horse-Shoe, dove la massa d’acqua accelerava avvicinandosi al dirupo per arrestarsi un attimo prima di gettarsi nell’abisso; scendere al livello del fiume per vedere dal basso l’abbattersi della cataratta; arrampicarmi sulle alture circostanti e contemplarla attraverso gli alberi; vedere il corso d’acqua ribollire nelle rapide e lanciarsi verso il suo spaventoso tuffo; attardarmi all’ombra delle rocce ieratiche, tre miglia più a valle; osservare il fiume che, rimescolato da una causa invisibile, si sollevava, turbinava e risvegliava mille eco sotto la superficie, lontano dal suo salto da gigante.
Horse-Shoe, dove la massa d’acqua accelerava avvicinandosi al dirupo per arrestarsi un attimo prima di gettarsi nell’abisso; scendere al livello del fiume per vedere dal basso l’abbattersi della cataratta; arrampicarmi sulle alture circostanti e contemplarla attraverso gli alberi; vedere il corso d’acqua ribollire nelle rapide e lanciarsi verso il suo spaventoso tuffo; attardarmi all’ombra delle rocce ieratiche, tre miglia più a valle; osservare il fiume che, rimescolato da una causa invisibile, si sollevava, turbinava e risvegliava mille eco sotto la superficie, lontano dal suo salto da gigante.  Avere il Niagara davanti a me, illuminato dal sole e dalla luna, rosso al finire del giorno e grigio quando la sera scendeva su di esso lentamente; averlo ogni giorno davanti agli occhi come paesaggio e svegliarmi la notte al suono della sua voce incessante e dirmi che queste acque avrebbero continuato a scorrere, precipitare, rombare e inabissarsi in tutte le stagioni e che le stesse iridescenze dell’arcobaleno avrebbero continuato a ricoprirle cento piedi più in basso. Quando il sole vi si posava sopra, esse brillavano come oro colato. Quando il cielo era coperto, le si sarebbe credute una valanga di neve o una grande collina di gesso in atto di franare o ancora una spessa fumata bianca che ricoprisse la roccia.
Avere il Niagara davanti a me, illuminato dal sole e dalla luna, rosso al finire del giorno e grigio quando la sera scendeva su di esso lentamente; averlo ogni giorno davanti agli occhi come paesaggio e svegliarmi la notte al suono della sua voce incessante e dirmi che queste acque avrebbero continuato a scorrere, precipitare, rombare e inabissarsi in tutte le stagioni e che le stesse iridescenze dell’arcobaleno avrebbero continuato a ricoprirle cento piedi più in basso. Quando il sole vi si posava sopra, esse brillavano come oro colato. Quando il cielo era coperto, le si sarebbe credute una valanga di neve o una grande collina di gesso in atto di franare o ancora una spessa fumata bianca che ricoprisse la roccia.Il torrente sembrava perennemente morire precipitando nel vuoto e sempre, dalla sua profondità insondabile, risorgeva quel tremendo fantasma di nebbia spumosa che non si posava mai, che ha oppresso questo posto con la stessa terribile solennità da quando l’Oscurità incombeva sull’abisso e alla parola di Dio irruppe nel Creato la Luce, la prima inondazione prima del Diluvio.




